Nick: P_Escobar
Oggetto: NON VEDO TERRA CAPITANO
Data: 14/10/2003 5.17.24
Visite: 159
Mai postato, racconto lungo e assolutamente fantasioso, tutto ciò che leggerete è inventato, eccetto ciò che è vero.
Finalmente stava finendo. L’estate più torrida di sempre si stava togliendo dai coglioni. Purtroppo oltre il caldo e l’umidità residui, dovevamo sorbirci i servizi in tv, che continuavano incessanti con le più ardite interpretazioni del fenomeno, appena inframezzati dalle notizie sulle recenti alluvioni che gli esperti avevano previsto, senza incertezze. Era stata per me un’estate particolare, avevo rosolato ben bene a 40° per quasi tre mesi i miei insuccessi e ora aspettavo con le finestre spalancate, la benevola brezza dei primi giorni di settembre, volgendo col cuore colmo di speranza il mio sguardo al nord. Ma era un’attesa non adeguatamente ricompensata, se non da rare folate di vento tiepido, che scuotevano appena le cime dei tre alberi in fila al centro della piazza di fronte casa mia.
Come era cambiato il tempo, una volta c’era l’anticiclone delle Azzorre, cazzo me lo ricordavo da ragazzino, quando il suo formarsi segnava inequivocabilmente l’avvento del periodo più caldo dell’estate. Si andava al mare, tranquilli, famiglie bagagli, tintarella e falò, tragici amori estivi che duravano l’ebbrezza di un attimo. Poi dopo il venti agosto arrivavano le piogge, prima al nord, ma poi anche sulle spiagge del sud. Qualche giorno dopo tornavi in acqua, ma ti accorgevi che era finita, faceva più freddo e da lì a qualche giorno avresti caricato i bagagli sotto la pioggia e saresti tornato a casa. Ma questo una volta, quell’estate invece il ruolo del protagonista fu interpretato da un inedito anticiclone africano, detto anche più confidenzialmente bolla africana, avrebbe regolato lui in futuro il clima estivo del nostro paese aggiunsero immancabilmente gli esperti e riuscirono a provocarmi lunghi brividi di terrore. Avevo sempre odiato l’estate, e parlo delle estati di una volta, quelle normali, quelle che a giugno faceva caldino e pioveva anche un po’, a luglio un po’ più caldo e così via. Figuriamoci questo infernale cocktail che miscelava sapientemente caldo fra 35° e 40° e umidità amazzonica, fino a raggiungere picchi insopportabili che si erano portati via migliaia di vecchi in tutta Europa.
Ma il caldo per quanto tenace, vischioso come colla da manifesti, insostenibile come l’alito di una vecchia ubriacona rifatta, col fegato a pezzi e i denti marci, che tenta di infilarti la lingua in bocca e le mani sull’uccello, senza sapere che il canarino in questo stato è clinicamente morto, era l’ultimo dei miei problemi. Amore, lavoro e quindi soldi, amici, droga e quindi ancora soldi, in ordine sparso erano le piaghe del mio personale calvario. Era andato tutto a rotoli o a puttane se preferite, oppure ancora, tutto era andato a farsi fottere per quelli che non possono fare a meno del potere evocativo delle parole. Comunque l’avreste messa non sarebbe cambiato un cazzo: ero al tappeto.
Prima l’amore, un diretto incassato a giugno dell’anno prima, preceduto in verità da una fitta schermaglia di jeb e seguito diversi mesi dopo da un gancio sinistro e un uppercut devastanti, al tappeto come nei migliori western, come se mi fossi imbattuto in aquila della notte e i suoi pards in un qualsiasi saloon di Tucson, El Paso, Frisco e senza riconoscerli, avessi scatenato la loro ira. L’avevo sottovalutata, avevo aperto la guardia e lei aveva colpito, un lavoro efficace devo dire, pulito, aveva fatto male, molto e con la stessa rapidità con cui aveva colpito era sparita. Oppure la stavo sopravvalutando ora, come sostenevano in coro, le tre donne con cui avevo una vaga relazione e che nonostante le loro affettuose attenzioni non riuscivo in alcun modo ad amare. Ero impermeabile, continuavo a loop a pensare a lei, spesso con dei riferimenti, dei luoghi, delle strade, delle vie che avevamo percorso insieme, di quello che ci eravamo detti, altre volte bastava un odore o il vento o la pioggia o anche un rumore. Insomma ero senza speranza, quasi tutti mi riportava inesorabilmente a lei, come una zanzara attratta da quei micidiali aggeggi elettrici che sembrano luce pura e invece in un attimo ti polverizzano, lasciando insieme ai brandelli di materia, un intenso odore di bruciato.
Poi il lavoro. I due gruppi con i quali avevo tirato su l’attività per dieci anni avevano deciso di dirsi ciao. Fottute rockstar del cazzo, tutte prese a misurare l’ampiezza media dei loro camerini e strepitare se qualcuno ce l’aveva più grosso. Mi ero sorbito per mesi insopportabili dialoghi a base di talento artistico, libertà artistica, esigenza artistica e nonostante il mio proverbiale stomaco di ferro, ero sinceramente nauseato da tanta esposizione all’arte. Avevo tentato ogni mediazione, nella rissa generatasi all’interno dei due gruppi avevo assunto un atteggiamento implacabile verso lo stato di degenerazione dell’esperienza, ma lodando contemporaneamente uno per uno i rispettivi membri. Bastone e carota, sparavo nel mucchio, quindi contro nessuno, un puro fatto di boom, innocuo, acustico sembrava stessi sparando con la bocca e lodavo invece i singoli e il loro atteggiamento sempre tollerante, sempre incline al dialogo, sempre prezioso per la carriera artistica della band. E non che dicessi cose del tutto false, c’era del buono in tutti loro, ma dopo dieci anni può capitare che una persona ti diventi del tutto intollerabile. Puoi anche arrivare a detestarla, senza che necessariamente ti abbia fatto qualcosa. Succede fra tutti, figuratevi fra persone che nel corso di dieci anni hanno trascorso gran parte della loro esistenza a strettissimo contatto. Sono i piccoli rancori, le divergenze non espresse nei tempi e nelle forme giuste che diventano cancro, che divora da dentro, rende una persona invisa come se avesse ucciso nostra madre.
Ero allo sfascio e ne ero consapevole, tuttavia guardavo la mia vita con stupefacente distacco. Tutto accadeva davanti a me in maniera chiara, ogni cosa aveva un andamento assolutamente leggibile. Eppure osservavo come se la cosa non mi riguardasse, in alcun modo, non ero io quel vecchio ragazzo che vedeva la sua vita sfasciarsi un pezzo dopo l’altro restando immobile. Pesavo quasi ottanta kg, record assoluto di tutti i tempi e per uno alto intorno al metro e settanta, vi assicuro che non era un bel vedere. L’orrenda calura mi aveva costretto ad osservare dietro ridottissimi indumenti lo spettacolo indecoroso del mio corpo che si allargava a dismisura. Non mangiavo neanche molto, ma il vero problema era che non facevo letteralmente un cazzo, niente dalla mattina alla sera avrebbe detto l’uomo medio. Avevo un ciclo biologico spostato di diverse ore rispetto ai tempi naturali del giorno e della notte, oltre che di quello ufficiale del paese in cui vivevo. Mi addormentavo raramente prima delle sette di mattina. Trascorrevo la notte a guardare film sulla tv satellitare, cazzeggiare sul web e quando ormai i fornai si preparavano gaudenti e felici a tirare fuori dal forno delle croccanti forme di pane, e si davano confortanti pacche sulle spalle, sorridendosi a bocca larga l’un l’altro, io decidevo che stavo per andare a letto. A volte pensavo che dormivo in simultanea con un sacco di newyorkesi perbene, solo che quando loro a Staten Island, a Manhattan o chi sa cazzo dove, si infilavano nel confortevole fodero climatizzato al chiaro di luna, qui era giorno e un intero mondo si ridestava, evocato dall’orribile cinguettio degli uccelli. Andare a letto poi significava in realtà che iniziavo a leggere. Quello della lettura è un vecchio trucco degli insonni e in genere funziona, nel mio caso però dal momento in cui aprivo il libro a quello in cui letteralmente svenivo passavano almeno un paio d’ore. Era l’unico modo per addormentarmi, farmi sorprendere a tradimento da un agguato rapido e indolore. Viceversa se pensavo invece di dire: ehilà mondo, buonanotte, vado a nanna, entravo in camera, spegnevo la luce, me ne stavo un bel po’ nel buio con gli occhi aperti che circumnavigavano nervosamente le quattro mura della mia stanza e il cervello che continuava a fare z z z, attivando collegamenti sinaptici. Non voglio dire che quando dormi non ci sono collegamenti sinaptici attivi, non ne so un cazzo sulla materia, salvo le quattro stronzate da medico in tv che sanno tutti e magari, facile, pure i veri medici. Ce ne saranno senz’altro di quei dannati collegamenti on. In ogni caso, potevano essere pure le sette di mattina, ero sveglissimo e col cazzo che avrei dormito.
Questo accadeva quasi sempre, diciamo che era il mio standard di vita. Quindi l’uomo medio nel mio caso avrebbe dovuto dire non fa un cazzo dal tardo pomeriggio fino al mattino del giorno dopo. A volte però, quando mi facevo di coca, l’intero ciclo subiva un ulteriore spostamento in avanti, direttamente proporzionale alla quantità di sostanza assunta. Quando dico facevo non parlo di merdate come farsi nelle vene. Nessun ago e zero sangue da queste parti dolcezze. Tiravo, aspiravo, pippavo, introducevo voluttuosamente white lady nel mio tormentato nasino, senza esitazione, fedele al motto: lo vuoi si chiede ai malati e io ero sano come un pesce e lo volevo sempre. Forse perciò dire a volte era un po’ giocare al ribasso, avere il cavallo buono e minimizzare con gli altri per evitare che troppe puntate abbassino le quote. Diciamo più realisticamente che capitava abbastanza spesso, almeno tre giorni su sette, con clamorosi exploits di sei su sette. Il ciclo era: pippavo, mi addormentavo in un lasso di tempo compreso fra le dieci del mattino e il pomeriggio inoltrato del giorno dopo, con conseguenti agghiaccianti risvegli fra mezzanotte e le quattro. Nell’ampia fenomenologia del mio ciclo vitale sotto l’effetto della cocaina, l’uomo medio avrebbe pertanto avuto serie difficoltà ad aggiungere alla frase non fa un cazzo una qualsiasi determinazione temporale e questo lo avrebbe senza dubbio messo in uno stato di agitazione. E che risvegli ragazzi, immerso nell’orrenda calura che spingeva il mio corpo a distillare ettolitri di purissimo sudore, abbondantemente corretto da coca, tossine, nicotina, catrame, tutta la merda del quintale di sigarette che avevo fumato e che il posacenere a terra vicino al letto mi ricordava con avvilente abbondanza di mozziconi. Dall’alcol che avevo bevuto a ettolitri, prima per tenermi su in effetto combinato con la coca e poi per invocare il sonno, cercando di annegare fra le misericordiose braccia di Bacco la netta, orribile consapevolezza compresa fra l’ultima pippata e il momento in cui il corpo lascia il cervello da solo a girare in folle e si abbandona allo stato di catalessi. La catalessi è forse l’ultima risposta dell’istinto di conservazione, apparire morto per conservare la vita, il penoso evitare per quanto possibile, il vis a vis con l’altra faccia della medaglia. Non c’è nulla dello stato di estasi dall’altra parte, dell’eccitazione che diverse ore prima ha accompagnato tutte le fasi dell’up, da quando la compri a quando ce l’hai in mano e un dolce languore ti attraversa le viscere, fino a quando arrotoli una banconota e te la spari dritta nella corteccia cerebrale. Sei solo con i demoni che ti ballano intorno al letto e in un cerchio sabbatico dicono ancora, ancora, ancora. Questo ha la coca, che ne vuoi sempre, la frase più tipica che ho sentito dire nel corso degli anni a svariati afiocionados della sostanza è che non ne basta mai ed è fondamentalmente vero. Una simpatica gag che facevamo nel mio giro di amici era che alla domanda “ne vuoi?” Si rispondeva con un “esiste una risposta diversa da si?” Quanto sfoggio di sagace retorica per dare una parvenza di razionalità al nostro io desiderante al suo stato più puro. Del resto puoi anche assecondare i demoni e fartene ancora, però a parte i problemi di portafoglio e miocardio, la fottuta cocaina agisce su certi recettori che si riducono pippata dopo pippata, per cui arrivato a un certo punto è come se ti presentassi fischiettando a casa, tiri fuori la chiave tutto allegrotto e non trovi più la toppa della serratura. Restavo spesso fuori casa, infilavo una nuova chiave bianca su per il naso, ma dall’altra parte non c’era nulla in cui potesse girare, solo l’incartapecorimento senza speranza. Converrete che addormentarsi in una simile condizione era un’impresa disperata e lo svenimento al quale mi affidavo quando avevo tirato cocaina, cercavo di alimentarlo anche con qualche ottimo spinello dal forte contenuto di thc. Sarebbe stato buono fumare a oltranza, l’hashish abbiocca, però il problema era che le canne qualcuno le deve fare e di conseguenza se sei solo te le devi rollare. Con la coca ero troppo frenetico o troppo impallato, l’equilibrio non è esattamente il compagno di coppia ideale per il campionato di bowling delle sostanze stupefacenti e in tutte e due i casi un’operazione così lunga e macchinosa come il rollare un bombolone non c’entrava assolutamente un cazzo con lo sballo che avevo in testa. Andavo veloce, pensavo dieci volte più veloce, il tempo si dilatava in forme assolutamente irregolari e l’ansia era in agguato perenne, cioè non potevo fare la stessa cosa per cinque minuti di fila, non esisteva proprio. E poi le mani che tremavano, ma non come un tossico di roba, non c’entriamo niente con quelli, apparteniamo a un’altra congrega. Se invece ero in down dovevo necessariamente stare disteso, immobile al buio a lasciare la testa e il corpo nell’inattività assoluta, più disperata via via che l’effetto della coca svaniva e lasciava al suo posto un enorme cratere. La disperazione di quel lungo, tormentato attimo conduceva in alcuni casi ad abbandonarsi all’abbraccio protettivo dell’eroina. La roba aveva la capacità unica di riconciliarti col mondo, almeno con quello schifo sparso a 360° intorno a te che era il tuo mondo. Tutto appariva improvvisamente al suo posto, eri lì disteso, ma forse sarebbe più corretto dire stramazzato, che contemplavi quasi come fossi all’esterno del tuo corpo lo spettacolo della miseria infinita in cui eri contemporaneamente carnefice, vittima, attore e spettatore. Non mi piaceva la roba, come confidenzialmente i tossici chiamano l’ero, o meglio l’avevo provata solo qualche volta, sufficienti a capire che quella calma ovattata, quell’oblio stragoduto dei sensi, sarebbe stato un rimedio senza dubbio peggiore del male. C’erano finiti in molti con la testa dritta dritta in quel cesso polveroso e biancastro, soprattutto quelli che la coca avevano cominciato a fumarla. La preparazione era lenta e laboriosa, si versava la sostanza in un cucchiaio, si aggiungeva dell’acqua e del bicarbonato o dell’ammoniaca e si scaldava l’intruglio. Questo permetteva alle sostanze da taglio di liquefarsi e contemporaneamente isolava la coca al suo stato più puro. Il risultato della complessa operazione erano delle pietruzze bianche durissime che venivano fumate in delle improvvisate pipe, costituite da una bottiglietta di plastica di acqua minerale riempita d’acqua per due terzi, con un foro nel quale s’infilava la cannuccia di una penna a sfera e sopra, al posto del tappo, uno strato di carta argentata tenuto stretto da un elastico, nel quale venivano praticati con la punta di uno spillo dei piccolissimi fori. Alla sommità di questo infernale strumento di morte, costruito perversamente assemblando oggetti innocenti, c’era un sottile strato di cenere di sigaretta che fungeva da braciere. Non era crack, ma pasta basica o free base e fumarla aveva degli effetti molto simili a quelli di una spada di bamba sparata dritta in vena. Sballo immediato, una decina di minuti di assoluto lost in space, col cuore a mille che sembra volerti uscire dalla gabbia toracica. Poi il desiderio di un’altra pipa e lo stato di estasi durava questa volta un po’ meno, sempre di meno, via via che continuavi ad attaccarti a quella bottiglietta velenosa. Se pippare con gli amici, aveva almeno una parvenza di calore umano, di sballo socialmente sostenibile, di coadiuvante per serate sopra le righe (era proprio il caso di dirlo), fumare svelava immediatamente la sua natura di sballo per lo sballo. Non te ne fregava un cazzo di riempirti la bocca di stronzate, fare il gallo cedrone in un locale finché l’effetto della bamba ti teneva su, te ne stavi da solo in un angolo, con la tua bottiglia dei miracoli, aspettando con ansia crescente in un silenzio da oltretomba, la tua pietra della felicità. Così era successo che molti bravi ragazzi, onesti consumatori quasi occasionali, diventassero dei tossici fatti e rifiniti, perché dopo l’ultima fumata era davvero indescrivibile l’orrendo stato in cui precipitava la tua mente. Solo l’ero poteva placare il dolore, far tacere quell’ammasso urlante e grigiastro che una volta era stato il tuo cervello e infatti nella roba si infognarono quasi tutti, diventando in alcuni casi esclusivamente tossici e abbandonando la coca da cui pur erano partiti e che non gli aveva negato delle sincere soddisfazioni. Io invece restavo fedele a guardia di un bidone colombiano, inventavo sempre nuovi modi per assecondare il mio svenimento post ultima assunzione e qualunque fosse stato l’esito, lo avrei considerato più sostenibile dell’irreale stato di pace nel quale ti precipita la merdosa eroina. Non mi sarei messo in fila con una massa di coglioni con uno spiedo infilzato nel culo per partecipare al barbecue di messer Belzebù, il culo nel caso me lo sarei bruciato da solo e questa folle e argillosa determinazione mi faceva in qualche modo sentire coi piedi a terra.
Questo era lo sfondo della mia estate. Mi drogavo, avevo un altro bioritmo a metà fra i mesi lunari, la media del fuso orario di 36 città sparse nei cinque continenti e il cinguettio degli uccelli. Amavo una donna che chi sa dov’era, le mie entrate economiche erano legate all’esito della tempesta che aveva investito un’accolita di stronzi fragili mocciosi ultratrentenni e non vedevo segnali incoraggianti. Ovunque mi girassi non ne vedevo di terra capitano, però qualcosa dovevo fare e avrei navigato, anche affrontando l’ira del mare a occhi chiusi, da lì dovevo muovermi e da qualche parte sarei approdato. |
 NON VEDO TERRA CAPITANO 14/10/2003 5.17.24 (158 visite) P_Escobar
NON VEDO TERRA CAPITANO 14/10/2003 5.17.24 (158 visite) P_Escobar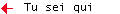
 re:NON VEDO TERRA CAPITANO 14/10/2003 13.21.59 (56 visite) Viol4
re:NON VEDO TERRA CAPITANO 14/10/2003 13.21.59 (56 visite) Viol4
 quando scrivi narrativa 14/10/2003 13.38.15 (56 visite) P_Escobar
quando scrivi narrativa 14/10/2003 13.38.15 (56 visite) P_Escobar
 no 14/10/2003 13.55.40 (53 visite) buendia
no 14/10/2003 13.55.40 (53 visite) buendia
 re:no 14/10/2003 14.10.59 (42 visite) P_Escobar (ultimo)
re:no 14/10/2003 14.10.59 (42 visite) P_Escobar (ultimo)