Premessa: non fa ridere, né vuole suscitare il riso. Magari, un po’ di riflessione.
Ero in chiesa, insieme ad altre decine di persone. E come in un film, rivedevo le immagini delle situazioni che ci avevano portato a questo. Ero andato via dal nostro paese per cercare fortuna. Alla sera non ne potevo più, di quelle quattro mura. Dei litigi, delle discussioni, che non c’era lavoro, che non si poteva quasi mangiare. La guerra era finita da pochi anni, e la ricostruzione era solo una parola con la quale qualcuno si riempiva la bocca. Mi vedo guardarmi intorno, senza uno spiraglio di uscire da questa situazione. E far pesare la rabbia su quelli che mi stanno intorno. Mi vedo racimolare qualche soldo e prendere un biglietto per quella che per noi era l’america, dove avevamo sentito che si stava bene, che c’era da mangiare e lavoro per tutti. Salgo su quella nave, lurida. Insieme a centinaia, forse migliaia, se non sapessi di esagerare direi milioni di altre persone, accatastato. Mi vedo, e ripenso alle immagini in bianco e nero che qualcuno mi ha imposto di vedere, dei prigionieri verso i campi di lavoro. non mi sentivo diverso, io. Ma speravo di tornare nel mio paese ricco, ricchissimo. E ci sarei tornato. Mi vedo scendere dalla nave, sotto lo sguardo severo dei funzionari del porto. Il mio nome, il mio paese, lo stesso colorito della mia pelle sono un marchio indelebile, me ne rendo conto da subito. Siamo poco di buono, siamo considerati meno di niente. Emigranti, clandestini o meno. Forza lavoro da sfruttare, tacciati di rubare il lavoro a qualche borghese del posto che non sa cosa possa significare avere veramente fame. E poi mi vedo lavorare in cantiere, a respirare il cemento per quindici ore al giorno, ad avvelenarmi di vapori ed a bruciarmi col calcestruzzo ancora fresco. Poi mi vedo lavorare in miniera, a dimenticare la luce del sole. Cominciare al mattino, prima dell’alba, e finire la sera, dopo il tramonto. Intanto la messa continua. Il prete va avanti con l’omelìa. Io sono arrivato al punto in cui ho veramente qualcosa. Niente di che, ma almeno un tetto sotto cui dormire. Conosco abbastanza bene la lingua, riesco a non farmi pesare troppo il mio essere un emigrante. E mangio, tutti i giorni. Ma evidentemente questo a qualcuno non va bene. Quel poco che mi sono guadagnato, me lo levano. Basta una piccola disputa con qualcuno che qui ci è nato, che gode di tutti quei diritti che io posso soltanto augurarmi di avere tra dieci, venti, trenta anni. Hanno sempre ragione loro. Sono diventato d’un tratto di nuovo il poco di buono che ero prima, senza una casa, senza lavoro. Forse questo non era il paradiso che ci aspettavamo. Senza essere riuscito a guadagnarmi un po’ di vita, con le mani distrutte e la schiena ingobbita, ho smesso di respirare per un “incidente sul lavoro”, dicono loro. Almeno quanto può essere un incidente un omicidio. Poi l’ultima immagine si è fermata sul coperchio di legno che scendeva, fino a chiudere la bara. Forse non avrei dovuto abbandonare l’italia per andarmene in australia, la nuova america. E già so che, come è successo in questi anni, l’ambasciata italiana continuerà a mandare lettere ai miei genitori dicendo che sto bene, che ho messo su famiglia, che ho un piccolo podere e che sto pian piano costruendomi un avvenire. Se prima leggevano queste lettere con orgoglio, ora le stracceranno con rabbia.
Un paese non meglio precisato della provincia di Napoli, 1970
ue' gianlù dimmi la verità, ma in quella foto..
il mio blog:
http://www.bananaamotore.splinder.com /  cercando l'america 8/10/2006 23.15.14 (90 visite) Nieth
cercando l'america 8/10/2006 23.15.14 (90 visite) Nieth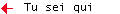
 re:cercando l'america 8/10/2006 23.21.58 (28 visite) leletta
re:cercando l'america 8/10/2006 23.21.58 (28 visite) leletta
 re:cercando l'america 8/10/2006 23.23.0 (22 visite) Nieth
re:cercando l'america 8/10/2006 23.23.0 (22 visite) Nieth
 re:cercando l'america 8/10/2006 23.22.27 (33 visite) bile
re:cercando l'america 8/10/2006 23.22.27 (33 visite) bile
 domenico rispondo io 8/10/2006 23.26.36 (26 visite) Mr.Bengal (ultimo)
domenico rispondo io 8/10/2006 23.26.36 (26 visite) Mr.Bengal (ultimo)