Nick: Franti
Oggetto: Gibbone
Data: 28/10/2005 10.14.27
Visite: 225
C’è un film bellissimo di Jim Jarmush, intitolato "Ghost Dog", dove c’è un bravissimo Forest Whitaker che interpreta la parte di un killer professionista, Ghost Dog. Che per agire si affida ad una sua personale Bibbia, "Il Libro dei Samurai, a cui fa costantemente riferimento.
Nel film Whitaker pronuncia una frase che fa più o meno così:
"Nel quartiere di Edo si usa una specie di cestino da pranzo intrecciato, che viene adoperato un solo giorno nelle passeggiate primaverili. Al ritorno lo si getta via calpestandolo. La fine è importante in tutte le cose.".
La fine è importante in tutte le cose.
Non ho alcuna cosa importante.
A volte mi sento come un Gibbone, aggrappato su un ramo, per un braccio.
Senza far nulla.
Quasi nell’attesa che il ramo si spezzi e finisca qualcosa, per vedere come andrà a finire.
E cosa succederà.
Io le cose le so iniziare.
Bene pure.
A finirle non ci riesco proprio.
Arrivo a metà e mi fermo.
Al massimo arrivo a tre quarti.
Poi mi fermo e non riesco ad andare avanti.
Oppure mi fermo perché non voglio andare avanti.
E’ stato sempre così.
Quando ero un bambino ed andavo al mare con i miei, ricordo che in spiaggia diventavo un grande ideatore di castelli di sabbia.
Un architetto in erba specializzato in costruzione di castelli di sabbia.
E così mi armavo di secchielli, palette e utensili vari e cominciavo a costruire questi castelli dalle forme più strane, con torri merlate, ponti levatoi e fossati.
Ma, arrivato a metà dell’opera, mi capitava di vedere in lontananza, al bar del lido, una bambina bionda con un Calippo in mano.
Abbandonavo il castello di sabbia e m’avviavo verso il bar.
M’avvicinavo da falso timido alla bambina bionda e le dicevo Ciao e poi le chiedeva se mi faceva assaggiare un po’ del suo Calippo.
Se la bambina bionda mi diceva "Sì", tutto si traduceva nella circostanza che non provava schifo per ma mia leccata sul suo Calippo e allora stringevo amicizia e mi batteva il cuore.
E dimenticavo il castello di sabbia costruito a metà o a tre quarti, sulla spiaggia.
Se la bambina bionda mi diceva "No", tutto si traduceva, invece, nella circostanza che provava schifo per ma mia leccata sul suo Calippo e allora imbarazzato dicevo "Vabbè scusa" e mi dirigevo verso il Juke Box e facevo finta di inserire una moneta per ascoltare una canzone.
E, nel frattempo, dimenticavo lo stesso il castello di sabbia costruito a metà o a tre quarti, sulla spiaggia.
Quando poi ritornavo sulla spiaggia il castello di sabbia costruito a metà o a tre quarti non c’era più.
Al suo posto mucchi scomposti di sabbia a placche.
Ovviamente non l’avevo distrutto io, bensì qualche bambino ignoto.
Questo perché non avrei mai avuto il coraggio di distruggere quel mio castello di sabbia, costruito a metà o a tre quarti.
Perché le cose, già da allora, non le sapevo finire.
La fine, anche in relazione a cose mie, era qualcosa che doveva riguardare gli altri, non me.
Questa era una circostanza che non sceglievo lucidamente, sia chiaro, ma era così che andava.
Quando mio padre e mia madre sono morti io non ho deciso proprio nulla.
Anzi, non mi rassegnavo.
Ho atteso che loro finissero, senza che io decidessi un cazzo.
Mia madre ha deciso di finire e lo ha fatto.
C’est fini.
Mio padre ha deciso di finire lo ha fatto.
C’est fini.
Credo loro abbiano considerato la loro vita con un senso ben preciso.
E hanno deciso di finirla una volta raggiunti certi scopi.
Hanno deciso di finirla in maniera gloriosa.
La loro fine deve essere stata importante per loro.
Per me no.
Per me loro hanno condotto una vita di merda ed un’esistenza, relazionata a me, che non è stata un granché.
Quasi un’inculata.
Me ne vergogno a volte di questa mia considerazione.
Forse è addebitale alla circostanza che non posso capire l’importanza della loro fine, visto che io le cose non le so finire.
Nelle mie storie d’amore o presunte tali non ho mai deciso la fine di una storia.
Per vigliaccheria, per abitudine, per egoismo, per il fatto che non riesco a rassegnarmi alla perdita di una persona a cui voglio bene, pur non amandola, o non so per cosa, non ho mai detto la parola fine ad una mia storia con una donna.
Lo hanno fatto loro per me.
Nella consapevolezza di non amarle più mi crogiolavo senza prendere alcuna decisione.
Le tradivo, qualche volta.
Mentivo loro per uscire con amici o per starmene da solo.
Mentivo pure a me stesso convincendomi che "E’ un periodo soltanto. Passerà".
Pur essendo consapevole che era finita.
Ma la parola fine mi faceva rabbrividire.
Le sfinivo ma non finivo.
Finivano loro, pure per me.
Un atto d’amore e di rispetto, credo.
Un atto d’amore e di rispetto che, credo, io non ho mai "usato" nel loro confronti.
Visto che finivano loro, anche per me
E allora ho avuto la consapevolezza che storie d’amore sono tali proprio perché finiscono.
Ma per loro che decidevano di finire.
Di finire per loro e per me.
Ma non per me che non avevo finito un emerito cazzo.
E così continuo a tenermi aggrappato ad un ramo, per un braccio.
E a dondolare nel vuoto.
Come un Gibbone.
Senza far nulla.
Quasi nell’attesa che il ramo si spezzi e finisca qualcosa, per vedere come andrà a finire.
E cosa succederà.
"Nel quartiere di Edo si usa una specie di cestino da pranzo intrecciato, che viene adoperato un solo giorno nelle passeggiate primaverili. Al ritorno lo si getta via calpestandolo. La fine è importante in tutte le cose.".
Anche questo scritto ha una fine che è una presa per il culo.
Continuo a fare il Gibbone.
Nick: luciesogni
Oggetto: nunziatella
Data: 25/10/2005 12.28.57
Visite: 10
nunzia, tu ke ne capisci, come si chiama quella canzone degli u2 che ha un assolo ke fa nananaaaanaaaaaaaaaaaa
nananaaaaaaaaaaaaana na naaaaaaaaa
ecc |
 Gibbone 28/10/2005 10.14.27 (224 visite) Franti
Gibbone 28/10/2005 10.14.27 (224 visite) Franti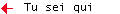
 re:Gibbone 28/10/2005 10.35.39 (61 visite) LaStrada
re:Gibbone 28/10/2005 10.35.39 (61 visite) LaStrada
 re:Gibbone 28/10/2005 10.37.45 (53 visite) Franti
re:Gibbone 28/10/2005 10.37.45 (53 visite) Franti
 Ps. 28/10/2005 10.38.48 (47 visite) Franti
Ps. 28/10/2005 10.38.48 (47 visite) Franti
 re:Ps. 28/10/2005 10.47.16 (42 visite) LaStrada
re:Ps. 28/10/2005 10.47.16 (42 visite) LaStrada
 re:Ps. 28/10/2005 10.50.30 (36 visite) Franti
re:Ps. 28/10/2005 10.50.30 (36 visite) Franti
 re:Ps. 28/10/2005 10.56.11 (35 visite) LaStrada
re:Ps. 28/10/2005 10.56.11 (35 visite) LaStrada
 re:Ps. 28/10/2005 11.1.11 (35 visite) Franti
re:Ps. 28/10/2005 11.1.11 (35 visite) Franti
 re:Gibbone 28/10/2005 11.1.45 (52 visite) jkm
re:Gibbone 28/10/2005 11.1.45 (52 visite) jkm
 re:Gibbone 28/10/2005 11.9.19 (50 visite) Franti
re:Gibbone 28/10/2005 11.9.19 (50 visite) Franti
 re:Gibbone 28/10/2005 11.16.15 (48 visite) jkm
re:Gibbone 28/10/2005 11.16.15 (48 visite) jkm
 re:Gibbone 28/10/2005 11.17.23 (37 visite) Franti
re:Gibbone 28/10/2005 11.17.23 (37 visite) Franti
 re:Gibbone 28/10/2005 11.19.55 (38 visite) jkm
re:Gibbone 28/10/2005 11.19.55 (38 visite) jkm
 re:Gibbone 28/10/2005 11.20.37 (42 visite) Franti
re:Gibbone 28/10/2005 11.20.37 (42 visite) Franti
 re:Gibbone 28/10/2005 11.22.40 (36 visite) jkm
re:Gibbone 28/10/2005 11.22.40 (36 visite) jkm
 re:Gibbone 28/10/2005 11.47.15 (33 visite) Franti
re:Gibbone 28/10/2005 11.47.15 (33 visite) Franti
 re:Gibbone 28/10/2005 12.4.55 (41 visite) jkm
re:Gibbone 28/10/2005 12.4.55 (41 visite) jkm
 re:Gibbone 28/10/2005 13.11.59 (41 visite) byZzZ
re:Gibbone 28/10/2005 13.11.59 (41 visite) byZzZ
 re:Gibbone 28/10/2005 14.27.6 (49 visite) Franti (ultimo)
re:Gibbone 28/10/2005 14.27.6 (49 visite) Franti (ultimo)
 ghost dog 28/10/2005 11.15.20 (51 visite) MASQUERAD
ghost dog 28/10/2005 11.15.20 (51 visite) MASQUERAD
 re:ghost dog 28/10/2005 11.17.55 (42 visite) Franti
re:ghost dog 28/10/2005 11.17.55 (42 visite) Franti
 re:ghost dog 28/10/2005 11.21.21 (33 visite) jkm
re:ghost dog 28/10/2005 11.21.21 (33 visite) jkm